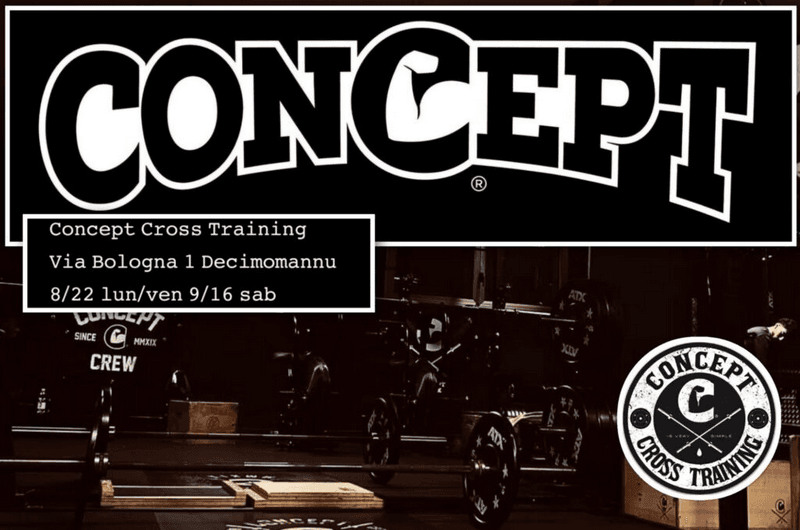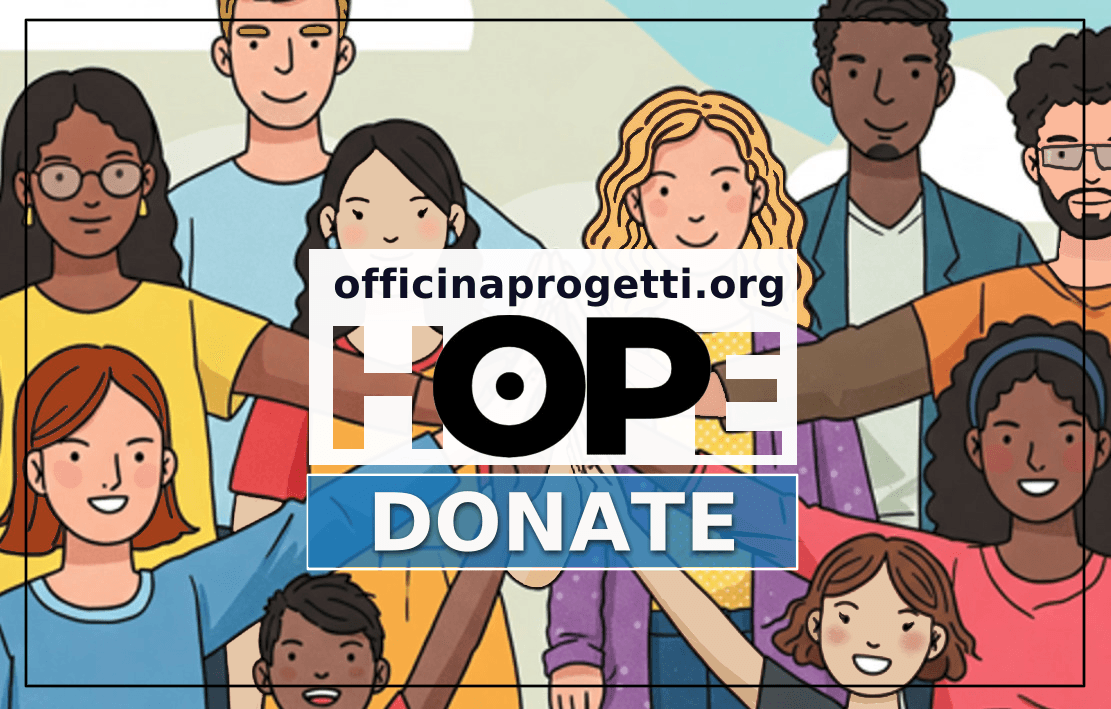Ci sono parole che scompaiono senza fare rumore. Non perché nessuno le pronunci più, ma perché vengono sostituite, levigate, lavate, ripulite e rese innocue.
Accade ovunque: in politica, nell’economia e nei media.
Non si parla più di precarietà, ma di flessibilità lavorativa. Non si dice più guerra, ma missioni di pace. Non si rivendicano più diritti collettivi, si promuove la meritocrazia inclusiva.
E quando si parla di tagli ai servizi sociali, si usa il temine riforma del welfare.
Sono solo parole, si potrebbe pensare. Ma le parole modellano il pensiero. Se un problema non ha più un nome chiaro, diventa più difficile riconoscerlo, discuterlo, combatterlo.
Non è un caso che parole vaghe e generiche ci confondano, impedendoci di afferrare la reale natura del discorso, sommergendoci nelle mille sfumature e contraddizioni che esse stesse creano.
Se non si usa più il termine “lotta di classe”, ritenuto troppo ideologico, sembra che la disuguaglianza sia un concetto superato.
Quando si smette di parlare di sfruttamento e si inizia a parlare di ottimizzazione dei processi, la disuguaglianza tra datori di lavoro e lavoratori diventa un fenomeno invisibile, difficile da criticare o riformare.
Le destre radicali hanno saputo manipolare il linguaggio per legittimare le proprie ideologie estremiste, sostituendo termini che evocano esclusione o intolleranza con espressioni più accettabili o persino positive.
Parole come sovranismo al posto di nazionalismo, difesa dell’identità culturale invece di xenofobia, e lotta contro l’invasione al posto di razzismo sono esempi di come la manipolazione linguistica consenta di mascherare l’intolleranza sotto l’apparenza di una legittima protezione della tradizione e dei valori nazionali.
Il patriottismo, così come la difesa della famiglia tradizionale, diventano strumenti per opporsi ai diritti civili, mentre ordine pubblico sostituisce la repressione, e sicurezza viene usata per giustificare politiche autoritarie.
Questo gioco con le parole rende più difficile opporsi a tali posizioni senza apparire contrari alla “difesa dei valori” o al “bene comune”.
George Orwell, nel suo celebre romanzo 1984, scritto nell’immediato dopoguerra, aveva compreso perfettamente un concetto fondamentale: il controllo del linguaggio è sinonimo di controllo della realtà.
Nel suo mondo distopico, Orwell introduce una lingua artificiale, la “Neolingua”, all’interno di una società dominata da totalitarismi che si dividono il mondo in tre superpotenze.
Questi regimi mantengono il potere attraverso una guerra perpetua, propaganda incessante e il controllo del pensiero, impedendo qualsiasi cambiamento sociale e tenendo la popolazione sotto stretto controllo.
Ogni governo riduce progressivamente il vocabolario, eliminando concetti ritenuti pericolosi e rendendo impossibile formulare idee sovversive. Se una parola non esiste, un pensiero non può essere nemmeno concepito.
Il rischio? Un mondo dove accettiamo quello che ci viene detto senza più metterlo in discussione.
Per questo, la lezione di Orwell è importante: quando qualcuno cambia le parole, chiediamoci sempre cosa ci sta facendo dimenticare.
Il linguaggio è potere. Dietro a ogni parola di denuncia che muta si nasconde il tentativo di controllare la società.