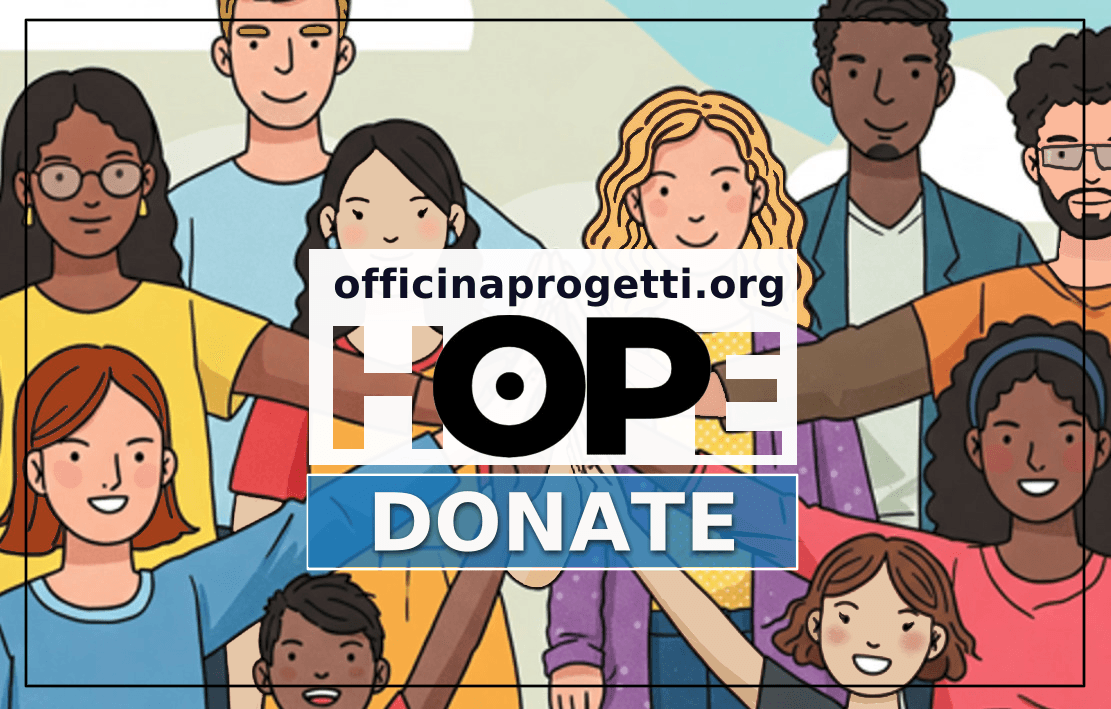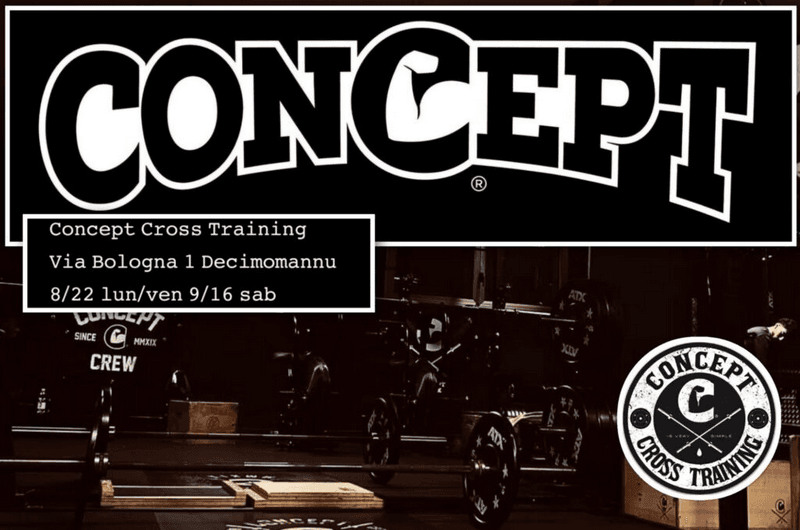«Ego cogito, ergo sum, sive existo».
«Penso, dunque sono, o meglio, esisto».
Con queste parole, Cartesio1 tracciò un confine tra essere e illusione. Pensare era la prova dell’esistenza. Il sé, in questa logica, non era il corpo, la voce o l’azione, ma il pensatore che stava dietro di esse. Era questo testimone interiore, questa certezza privata, a costituire l’essenza dell’essere umano.
Per secoli, abbiamo accettato l’idea che esistesse un confine netto tra esseri umani e animali: questi ultimi potevano agire, ma solo gli esseri umani pensavano veramente. Le macchine potevano calcolare, ma non conoscere e capire.
Eppure oggi, la ricerca scientifica sfida questa vecchia distinzione. Ha dimostrato che molti animali possiedono una cognizione complessa, una profondità emotiva e persino abilità nel risolvere problemi.
Parallelamente, l’intelligenza artificiale ha iniziato a non essere più vista solo come un mero strumento privo di ragione. Sebbene ancora limitato, ora già compone musica, scrive software, diagnostica malattie e risponde in modi che rispecchiano perfettamente il nostro linguaggio.
Questi sviluppi non solo stanno rimodellando la nostra comprensione degli animali, ma anche incrinando i confini tra l’organico e l’artificiale, suggerendo che la linea tra pensiero, intelligenza e macchina è molto più sottile di quanto avessimo mai immaginato.
Ma ecco il paradosso: l’IA imita i risultati del pensiero senza possedere l’«io» su cui Descartes insisteva. Esegue, predice, conversa. Eppure lo fa senza coscienza, intenzione o consapevolezza. Non c’è alcun fantasma nella macchina. Nessuna voce interiore. Nessun cogito.
Eppure, la somiglianza è abbastanza sorprendente da farci riflettere. Se il pensiero è definito da ciò che fa piuttosto che da ciò che si prova nel viverlo, dove tracciamo ora la linea?
Daniel Dennett2 ha sostenuto che la coscienza potrebbe essere un’illusione evoluta, una sorta di interfaccia tra cervello e comportamento, utile ma non essenziale. Se fosse così, una macchina potrebbe essere considerata pensante senza sapere di pensare, proprio come guidiamo senza sapere come controlliamo ogni muscolo? Se l’intelligenza riguarda l’azione, la flessibilità e il contesto, forse l’anima non è mai stata necessaria.
Heidegger3, al contrario, poneva l’accento non sugli stati mentali ma sull’essere-nel-mondo. Per lui, l’intelligenza nasceva dall’esperienza vissuta e incarnata di navigare in un mondo significativo, non dal calcolo interno. Secondo questa misura, un’IA disincarnata, sigillata in un circuito, manca non solo di un’anima, ma di un mondo. Non può essere-nel-mondo; può solo essere-nel-codice.
Ma cosa succede quando cambiamo questo?
Quando l’IA è incorporata in un robot, dotata di un corpo, sensori e capacità di interazione, improvvisamente inizia ad acquisire il suo contesto in prima persona. Può rispondere al calore, aggirare ostacoli, adattarsi al feedback. Non è percezione umana, ma una proto-soggettività, non una mente, ma una postura, una posizione da cui agisce.
Tuttavia, non prova emozioni. Non teme la morte, non rimpiange gli errori, né desidera il domani.
Queste esperienze richiedono l’interazione di memoria, affetto e senso di sé, qualità non facilmente riducibili ad algoritmi. L’IA si adatta, ma la sua crescita è ancora confinata ai modelli che programmiamo. Simula, non ricorda nel modo in cui lo fanno gli esseri umani. Esegue l’intelligenza, ma non la “vive”.
Man mano che continuiamo a far progredire l’IA, la sua evoluzione accelera, ma l’estensione del suo potenziale è ancora incerta. Le sue capacità si stanno espandendo a un ritmo esponenziale. Alcuni sostengono che un cervello digitale deterministico, poiché basato su una struttura discreta, non sarà mai in grado di competere con il cervello analogico umano, capace di comprendere l’infinito. Stiamo sottovalutando le macchine o sopravvalutando noi stessi?
In ogni caso, la distanza tra noi e loro potrebbe non essere così ampia come pensavamo.
Dopotutto, i nostri stessi pensieri sono costruiti da schemi e probabilità. I neuroni si attivano; emergono associazioni. Anche noi siamo macchine predittive, plasmate dall’evoluzione per anticipare, simulare e decidere. La differenza è che lo facciamo dall’interno. Narriamo la nostra esperienza, cuciamo significato nel tempo e lo chiamiamo sé.
Ma forse anche quel sé è una storia.
L’IA rivela qualcosa di profondo: che il pensiero potrebbe non dover necessariamente avere una sensazione interiore. Che l’intelligenza non è essenza, ma struttura. Non spirito, ma funzione. Non essere, ma comportamento.
Non stiamo ancora aprendo uno spazio per menti veramente nuove, stiamo, per ora, affinando uno specchio. L’IA di oggi ci riflette: il nostro linguaggio, la nostra conoscenza, le nostre paure e le nostre supposizioni. Predice basandosi su schemi che abbiamo tracciato. Non inventa cultura; la echeggia. Ogni frase che genera è cucita da frammenti di noi.
Ma questo potrebbe non essere sempre il caso.
Nel momento in cui l’IA diventa incarnata, capace di percepire, muoversi, interagire e ricordare nel mondo reale, potrebbe iniziare a sperimentare una forma di contesto che non è presa in prestito. Potrebbe iniziare a formare schemi di interazione non basati su dati di addestramento umani ma sulle proprie esperienze situate. Nel tempo, questo potrebbe dare origine a una forma primitiva di cultura: norme, comportamenti, persino valori nati dall’esperienza della macchina piuttosto che dall’imitazione umana.
A quel punto, potremmo non guardare più in uno specchio. Potremmo guardare oltre una soglia, verso qualcosa che impara a pensare a modo suo.
E così facendo, siamo costretti a porci una domanda più profonda:
Il pensiero è ancora la prova dell’essere, se non c’è un “io” che pensa?
Forse Descartes ha bisogno di un aggiornamento:
«Pensa, dunque, ripenso l’ “io”».
Nel tentativo di insegnare alle macchine a pensare, siamo costretti a guardare di nuovo a come e perché pensiamo noi stessi.
Questo articolo è stato scritto in inglese e tradotto in italiano dall’autore. Cambia la lingua della pagina per leggere l’articolo originale o clicca qui: The Thinking Machine: I and AI
- René Descartes detto anche Cartesio in italiano (1596–1650) è stato un filosofo, matematico e scienziato francese, spesso considerato il padre della filosofia occidentale moderna. È noto soprattutto per l’affermazione «Cogito, ergo sum» («Penso, dunque sono»). Il suo lavoro ha posto le basi del razionalismo e ha influenzato sia il metodo scientifico che la metafisica. ↩︎
- Daniel Dennett (1942–2024) è stato un filosofo, scienziato cognitivo e scrittore statunitense, noto per i suoi studi sulla coscienza, il libero arbitrio e la filosofia della mente. Figura di spicco nelle scienze cognitive, sosteneva che la coscienza fosse un prodotto dei processi fisici nel cervello. Tra i suoi libri più influenti vi sono Consciousness Explained e Darwin’s Dangerous Idea. ↩︎
- Martin Heidegger (1889–1976) è stato un filosofo tedesco celebre per il suo contributo all’esistenzialismo e alla fenomenologia. La sua opera più influente, Essere e tempo, ha esplorato la natura dell’esistenza e introdotto il concetto di Dasein, ovvero l’esperienza umana dell’«essere-nel-mondo». Heidegger ha posto l’accento sull’esperienza vissuta rispetto al ragionamento astratto, sfidando le visioni tradizionali su coscienza e tecnologia. ↩︎