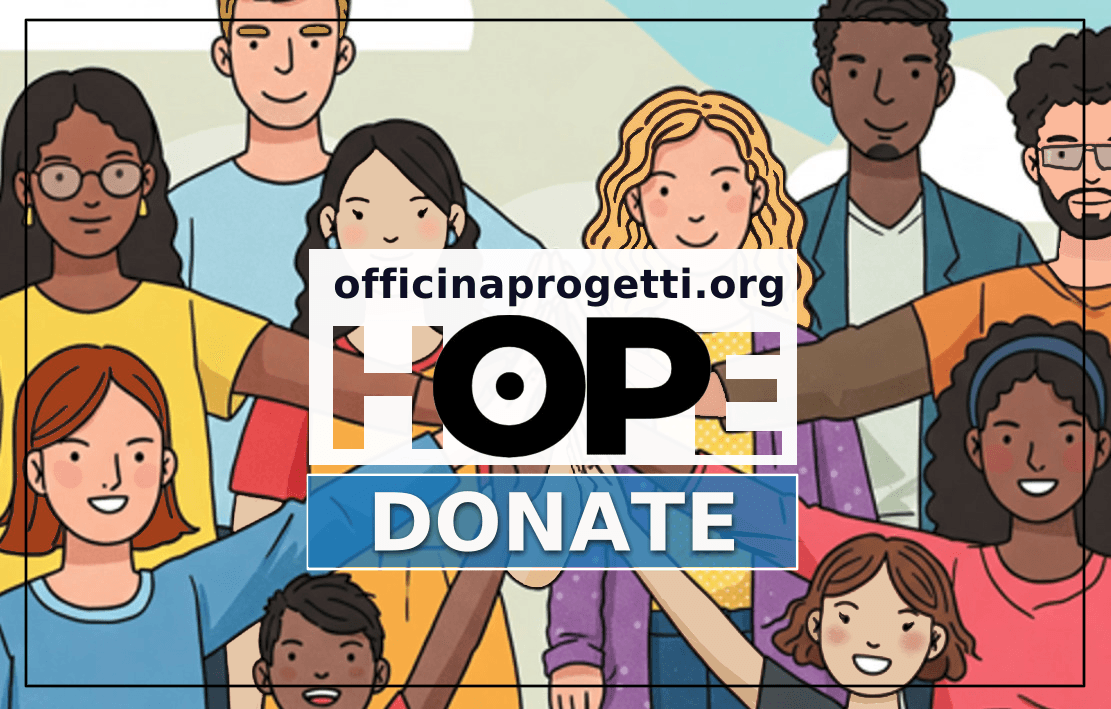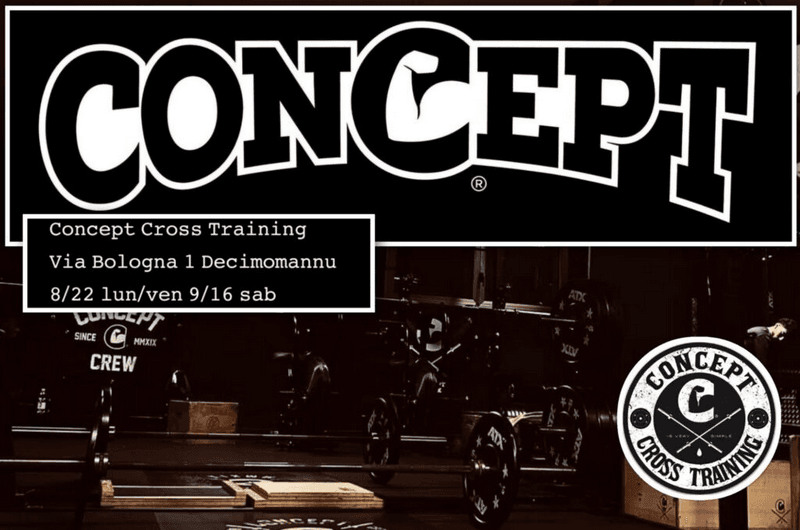Negli ultimi decenni la gestione delle migrazioni e delle frontiere esterne è diventata una delle sfide centrali per l’Unione Europea, tanto sotto il profilo politico quanto sotto quello giuridico.
A fronte di crisi umanitarie, pressioni migratorie e preoccupazioni legate alla sicurezza, l’UE ha progressivamente rafforzato i propri strumenti di controllo, fino alla creazione di un’agenzia dedicata: l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
La nascita e l’evoluzione di Frontex riflettono una trasformazione profonda del concetto stesso di frontiera in ambito europeo, passata da simbolo di integrazione a terreno di tensione tra esigenze di protezione e tutela dei diritti umani.
La Genesi di Frontex: contesto politico e normativo.
L’istituzione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera rappresenta il culmine di una strategia europea volta più al contrasto e, utopicamente, all’arresto dei flussi migratori, più che alla loro regolamentazione.
Per riuscire a inquadrare le ragioni storiche che hanno portato agli odierni risultati nel complesso campo della gestione dei flussi migratori è necessario andare indietro laddove cominciò il processo di formazione dell’Unione Europea come la conosciamo oggi.
Il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE), firmato a Roma nel 1957, poneva quale obiettivo lo sviluppo di attività economiche nell’insieme della Comunità “mediante l’instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri”, a tal fine prevedeva “l’eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone dei servizi e dei capitali”. Tuttavia il Trattato non specificava quali fossero gli ostacoli da rimuovere.
Si realizzeranno dei progressi nei tesissimi anni Settanta sotto la spinta della necessità di coordinare le politiche europee in materia di lotta al terrorismo. In particolare nel 1975 nel Consiglio d’Europa venne costituito il Gruppo “Trevi”, un primo segno di dialogo e apertura verso l’abbattimento delle frontiere interne dell’Unione.
Il primo concreto passo avanti nella storia della Comunità Europea fu la firma dell’Atto Unico Europeo, il quale pur assicurando la libera circolazione nel territorio dell’Unione di merci servizi e capitali, ma non delle persone, rappresentava comunque un doppio passo in avanti: stabiliva quali fossero gli ostacoli da rimuovere e imponeva un termine perentorio per la realizzazione del mercato interno.
Gli Stati membri, seppur concordi nella rimozione dei controlli relativi ai beni, servizi e capitali, avevano posizioni discordanti riguardo la circolazione delle persone, per questo motivo i progressi in tale ambito si mossero su terreni alternativi alle istituzioni europee.
Nacque una stretta collaborazione tra alcuni Stati europei, che portò il 14 giugno 1985 alla firma dell’Accordo di Schengen che prevedeva la progressiva abolizione delle frontiere interne dei Paesi firmatari allo scopo di favorire la libera circolazione delle persone e la facilitazione degli scambi di merci e servizi.
La logica alla base del “Sistema Schengen”, e, da questo momento in poi, di ogni altra decisione relativa alla libera circolazione delle persone, lega tale libertà alla diminuzione dei livelli di sicurezza dei cittadini, ragion per cui gli Stati firmatari, parallelamente alle misure facilitatorie dei movimenti, misero in atto una serie di misure compensatorie per garantire ai cittadini livelli di sicurezza pre-Schengen.
Nacque il concetto di frontiera esterna, una linea che segnava il perimetro di un’area nella quale erano ricompresi tutti gli Stati contraenti, che abolivano i controlli alle frontiere comuni, quelle interne, trasferendoli per converso alle frontiere “esterne” (quelle tra uno Stato contraente e uno Stato non contraente) nel cui controllo, ciascuno Stato era tenuto a prendere in considerazione anche l’interesse degli altri.
Allo stesso tempo le iniziative di Bruxelles, anch’esse orientate all’obiettivo ultimo di abolire le frontiere all’interno della Comunità Europea proseguivano parallelamente alle iniziative di Schengen senza incontrarsi, almeno nelle fasi iniziali.
Con il Trattato di Maastricht (1993), la Giustizia e gli Affari Interni entrarono nel terzo pilastro dell’UE, mantenendo però un’impostazione intergovernativa. Il Trattato di Amsterdam (1997) segnò una svolta, trasferendo le competenze su visti, asilo e immigrazione al primo pilastro comunitario, sancendo l’integrazione dell’acquis di Schengen nel framework europeo e creando formalmente lo Spazio di Libertà Sicurezza e Giustizia (SLSG).
Nel 1999 a Tampere (Finlandia) si tenne il primo Consiglio europeo interamente dedicato alla Giustizia e Affari Interni, l’obiettivo del vertice era discutere le future direzioni della cooperazione alla luce delle novità introdotte dal Trattato di Amsterdam.
Tra i capisaldi che avrebbero dovuto guidare le scelte politiche figurano l’impegno al rispetto della Convenzione di Ginevra (e con essa del principio di non-refoulement), infatti “Sarebbe contrario alle tradizioni europee negare tale libertà a coloro che sono stati legittimamente indotti dalle circostanze a cercare accesso nel nostro territorio”, e la previsione “di un controllo coerente alle frontiere esterne per arrestare l’immigrazione clandestina e combattere coloro che la organizzano commettendo i reati internazionali ad essa collegati”.
A tale scopo il Consiglio europeo prevedeva “controlli efficaci alle future frontiere esterne dell’Unione da parte di professionisti qualificati e specializzati”. L’embrione che nel 2005 darà vita a Frontex si impiantò.
L’11 settembre del 2001 l’attacco terroristico alle Torri Gemelle di New York, costato la vita a 2.974 persone, fece fermare il mondo intero.
L’Unione Europea, in questo scenario internazionale di paralisi da terrorismo islamico, rispose in modo quanto mai celere. Il 15 novembre 2001 fu redatta dalla Commissione una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo “su una politica comune in materia di immigrazione illegale” la quale prevedeva una politica comune centrata sul controllo e la difesa delle frontiere esterne dell’UE, da realizzare mediante misure che rafforzavano la sorveglianza (visti, controlli, rimpatri) e individuava “L’istituzione di una Guardia di frontiera europea quale elemento fondamentale di tale strategia”.
Nel 2004, con l’ingresso di 10 nuovi Stati, l’UE visse il più grande allargamento della sua storia. L’estensione delle frontiere esterne, incluse Cipro e Malta, sollevò timori su un possibile indebolimento dei controlli e pressioni migratorie sui nuovi membri, ritenuti fragili sotto il profilo tecnico ed economico.
La concomitanza dei timori legati al terrorismo di matrice islamica, la diffidenza verso i nuovi arrivati, la complessità degli accordi di cooperazione, le difficoltà linguistiche e non ultime le difficoltà economiche riscontrate da alcuni Stati di frontiera sui quali bilanci nazionali ricadevano i costi dei controlli, compromettevano la buona riuscita della vigilanza di frontiera, accelerando contemporaneamente la nascita di Frontex.
Fu così che su proposta della Commissione europea, del novembre del 2003, fu istituita in tempi brevissimi, il 26 ottobre 2004, l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione Europea un “organismo comunitario dotato di personalità giuridica” con sede a Varsavia in Polonia che iniziò ufficialmente ad operare il 3 ottobre 2005.
L’Agenzia, come scritto sulle prime righe del regolamento 2007/2004, trova la sua base legale nell’art. 62, paragrafo 2, lettera a), e nell‘art. 66 del Trattato istitutivo della CE.
Il primo prevede l’adozione di norme e procedure standardizzate a cui gli Stati membri devono attenersi per l’effettuazione dei controlli sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli stessi, il secondo conferisce al Consiglio il potere di adottare misure che garantiscano la cooperazione in materia di asilo immigrazione e altre politiche legate al movimento delle persone.
Il Regolamento del 2004 individua al secondo capo sei compiti principali dell‘Agenzia, tutti volti alla cooperazione e coordinamento con gli Stati membri in materia di controllo dei confini esterni, e supporto nelle operazioni di rimpatrio.
Fin dalla sua nascita era previsto che Frontex dovesse dotarsi di un “Corpo nazionale delle guardie di frontiera”, il regolamento inoltre poneva l’accento sul fatto che, pur essendo uno strumento facente parte del primo pilastro (quindi sovranazionale), gli Stati membri potessero collaborare a livello operativo con Paesi terzi qualora tale collaborazione fosse complementare all’azione dell’Agenzia.
I Paesi vincolati dall’applicazione del regolamento furono tutti gli Stati membri più Norvegia e Islanda le quali, pur non essendo membri UE, partecipavano agli accordi di Schengen, vi era inoltre la previsione di alcune eccezioni relative a Regno Unito Irlanda e Danimarca.
Amministrativamente l’Agenzia è governata da un Consiglio di Amministrazione, incaricato di definire gli indirizzi strategici, approvare il bilancio e nominare il vertice. Alla guida operativa vi è un direttore esecutivo, responsabile dell’attuazione delle decisioni del Consiglio e della gestione quotidiana dell’Agenzia, il quale può essere assistito da uno o più vice direttori e da una struttura tecnica e amministrativa centrale.
Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta, i finanziamenti derivano da quattro componenti “un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell’Unione Europea, un contributo dei paesi terzi associati all’attuazione, compensi per i servizi forniti e contributi volontari degli Stati membri.”
Riforme potenziamento e controversie.
L’evoluzione del quadro normativo europeo, culminata con il Trattato di Lisbona (2009), aveva già conferito all’Unione un ruolo rafforzato nella gestione delle frontiere esterne, delineando un sistema integrato fondato sulla solidarietà tra Stati membri, tuttavia emersero presto i limiti strutturali e operativi di Frontex.
In quegli anni si assistette al susseguirsi di forti ondate migratorie, la prima cominciò alla fine del 2010, in conseguenza del vuoto di potere creatosi negli Stati del Nord Africa in seguito alla “primavera araba”, la seconda, verificatasi nel 2015, fu caratterizzata da un afflusso senza precedenti di migranti e rifugiati lungo la rotta del Mediterraneo orientale e dei Balcani.
L’agenzia, concepita inizialmente come organismo di supporto tecnico e di coordinamento, si rivelò inadeguata a fronteggiare un’emergenza di tale portata, priva com’era di mezzi propri e di poteri coercitivi.
Queste crisi diedero la spinta necessaria a una profonda riforma dell’agenzia, avviata con il Regolamento (UE) 2016/1624, che sancì la nascita della “Guardia di frontiera e costiera europea” determinando un notevole rafforzamento delle capacità operative dell’UE in materia di controllo migratorio.
Il Regolamento del 2016, di impronta fortemente securitaria ed emergenziale normalizza l’approccio hotspot, un meccanismo basato sull’accoglienza dei migranti in strutture situate vicino ai principali punti di sbarco in cui le autorità nazionali, con il supporto di agenzie europee come Frontex, Europol, EASO e EUAA, si occupano di identificare, registrare e fotosegnalare i migranti.
A seguito di queste operazioni viene effettuata una prima distinzione tra richiedenti asilo e migranti irregolari: i primi vengono avviati alla procedura d’asilo, mentre i secondi sono soggetti a rimpatrio, il quale avviene con la collaborazione di Frontex.
Inoltre il meccanismo hotspot era (ed è) considerato funzionale alla redistribuzione delle persone bisognose di protezione internazionale tra i vari Stati membri anche allo scopo di alleggerire i Paesi di frontiera, i quali si trovavano in prima linea a fronteggiare fortissime pressioni migratorie.
L’urgenza di un’azione coordinata e centralizzata – espressione concreta del principio di solidarietà codificata dall’art. 80 TFUE – condusse infine all’adozione del Regolamento (UE) 2019/1896, che trasformò Frontex in un attore strategico dell’integrazione europea in chiave securitaria, dotandolo di un corpo permanente, con una capacità di 10.000 membri da completarsi entro il 2027, maggiore autonomia e un budget significativamente aumentato.
Si pensi che dal 2005 a oggi, complessivamente, il budget dell’Agenzia è aumentato di più del 140% passando da poche decine di milioni a quasi un miliardo annuo, non a caso si definisce “The fastest growing EU Agency”.
Questa escalation riflette la crescente securitizzazione delle frontiere esterne UE, con nuovi investimenti in personale, droni, sorveglianza e infrastrutture operative.
A fronte del consistente e continuo incremento di budget, effettivamente l’agenzia ha raggiunto considerevoli risultati: nel 2024 gli attraversamenti irregolari alle frontiere esterne sono stati poco più di 239.000, il livello più basso dal 2021, con un crollo del 38% rispetto al 2023, nel 2024 i rimpatri assistiti sono aumentati del 43%, 43.508 migranti sono stati soccorsi in mare.
Tuttavia le politiche attraverso le quali l’agenzia realizza tali risultati spesso risultano essere controverse e nel corso degli anni l’agenzia è stata oggetto di numerose inchieste giornalistiche.
Nel 2019 il Fondo Europeo per la Difesa, ha supportato l’agenzia con un investimento di 100 milioni di euro per l’acquisto di droni, tale investimento sarebbe avvenuto in concomitanza con la decisione di ritirare le missioni navali di Frontex dal Mediterraneo.
Sebbene queste unità non fossero formalmente incaricate di operazioni di ricerca e soccorso, il diritto marittimo internazionale le obbligava comunque a prestare assistenza ai naufraghi incontrati in mare. L’Agenzia è stata accusata di aver deliberatamente adottato una strategia incentrata sulla sola sorveglianza aerea delle frontiere marittime, con l’obiettivo implicito di eludere tale obbligo di soccorso.
Appena un anno dopo, Lighthouse Reports in collaborazione con Der Spiegel e Bellingcat si è occupata dei presunti respingimenti illegali operati dall’agenzia nel Mar Egeo.
L’inchiesta ha rivelato abusi, violazioni dei diritti umani e respingimenti irregolari fornendo ulteriori prove ai casi già presentati alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
La situazione è ulteriormente degenerata quando Frontex, invocando la sicurezza operativa, si è rifiutata di fornire un resoconto completo delle proprie attività nell’Egeo, negando ogni coinvolgimento nei respingimenti illegali e scaricando di fatto ogni responsabilità sulle autorità greche, sostenendo che le sue unità operano sotto il comando nazionale.
Frontex è stata oggetto di accuse da parte di numerose organizzazioni internazionali non governative le quali denunciano violazioni del principio di non-refoulement, uso della violenza, violazioni dei diritti umani, poca trasparenza nella gestione del budget.
Le gravi e numerose denunce ricevute dall’Agenzia hanno portato il 28 aprile del 2022 alle dimissioni dell’allora direttore Fabrice Leggeri.
Il percorso che ha condotto alla nascita di Frontex e alla sua successiva trasformazione riflette le profonde tensioni tra sicurezza e diritti umani che attraversano la politica migratoria dell’Unione Europea.
Da semplice organismo tecnico di coordinamento, Frontex si è progressivamente evoluta in un attore centrale della governance delle frontiere esterne, dotato di crescenti poteri, risorse e capacità operative. Tuttavia, tale rafforzamento ha spesso privilegiato un approccio securitario, a scapito della tutela dei diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo.
Le riforme successive alle crisi migratorie del 2011 e del 2015 hanno tentato di colmare le lacune operative evidenziate dalle emergenze, ma non hanno sempre assicurato un equilibrio tra efficienza nei controlli e rispetto delle norme internazionali. Le ripetute denunce di violazioni dei diritti umani, le inchieste giornalistiche e le indagini giudiziarie testimoniano un crescente scollamento tra gli obiettivi dichiarati e le pratiche effettive dell’Agenzia.
L’esperienza di Frontex evidenzia, in ultima analisi, la necessità di una revisione profonda del paradigma europeo in materia di migrazione e frontiere, che ponga al centro non solo la protezione dello spazio comune, ma anche la dignità e i diritti delle persone che lo attraversano. Solo una politica migratoria realmente integrata, solidale e rispettosa dei valori fondanti dell’Unione potrà garantire risposte efficaci e sostenibili alle sfide del presente e del futuro.
Bibliografia
Volumi:
Brunazzo M. e Della Sala V. (2019), La Politica dell’Unione Europea, Mondadori.
Cini M. and Pérez-Solórzano Borragán N. (2022), European Union Politics, Oxford University Press, 7th edition.
Duta R.A. (2017), La securitizzazione dell’immigrazione come guida delle scelte politiche, Università degli studi Roma Tre, tesi di dottorato di ricerca in scienze politiche studi europei e internazionali, https://arcadia.sba.uniroma3.it/handle/2307/40480
Scquizzato E.(AA 2029/2020), L’evoluzione del ruolo di Frontex nella gestione delle frontiere esterne dell’unione europea,Università degli studi di Trento, tesi di laurea magistrale in giurisprudenza, https://www.meltingpot.org
Documenti:
*Tutti i documenti prodotti dall’Unione Europea e dai suoi organi, utilizzati per supportare quanto affermato in questo elaborato sono reperibili sulla banca dati EUR-Lex, raggiungibile dal sito web: Diritto dell’UE – EUR-Lex.
Gui F., Un manifesto per i federalisti europei, pubblicazione Eurostudium gennaio-marzo 2011, https://www.istitutospinelli.it/download/il-manifesto-di-ventotene-italiano/?wpdmdl=637&refresh=6846d603b65781749472771
Conclusioni della presidenza, Consiglio europeo di Tampere 15 e 16 ottobre 1999, Consiglio europeo di Tampere 15-16.10.1999: Conclusioni della presidenza
Articoli:
“Ambiente società territorio” geografia nelle scuole, anno LXII n.3 luglio/settembre 2017, Rivista dell’associazione italiana insegnanti di geografia, https://www.aiig.it/wp-content/uploads/2019/07/Rivista_n03_17_lug_ago_compressed.pdf – page=11
Cucchi F. (2019), Controllo delle frontiere e violazione dei diritti umani lungo la rotta balcanica, pubblicazione online http://doi.org
Gatti M. (2016). La dichiarazione UE–Turchia sulla migrazione: un trattato concluso in violazione delle prerogative del Parlamento?. Articolo rivista EUROJUS, https://hdl.handle.net/11585/727471
UNHCR Italia, 2 maggio 2025, notizie “Mediterraneo centrale, UNHCR: ad aprile +173% di arrivi via mare, -2% rispetto al 2024”, https://www.unhcr.org