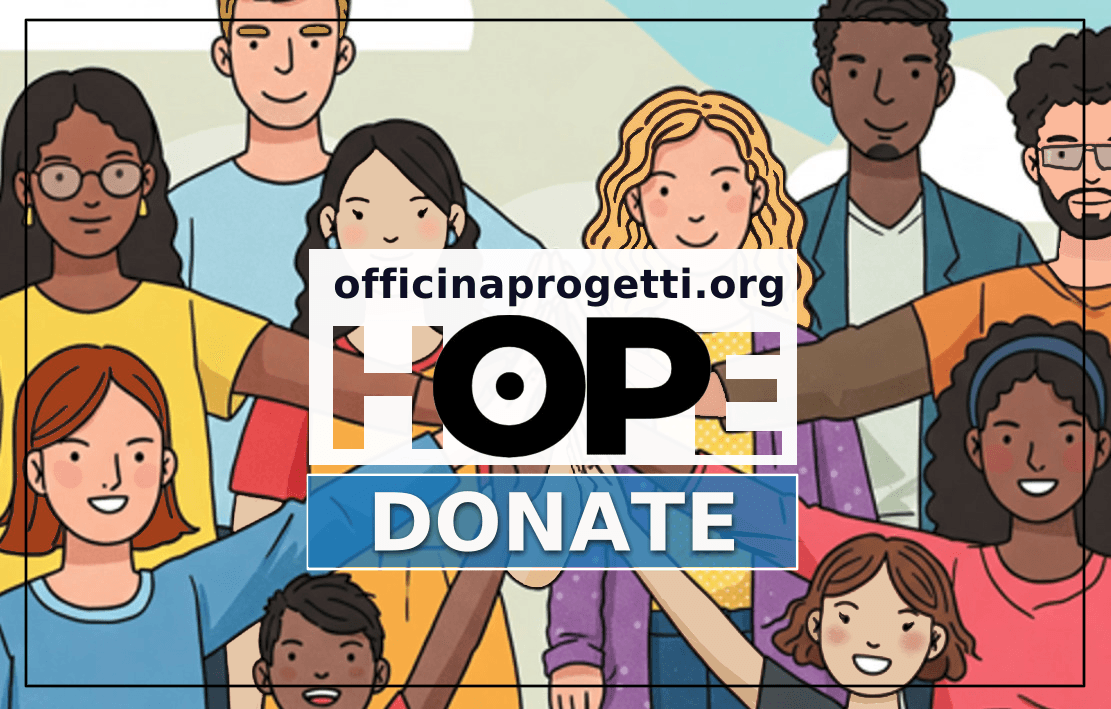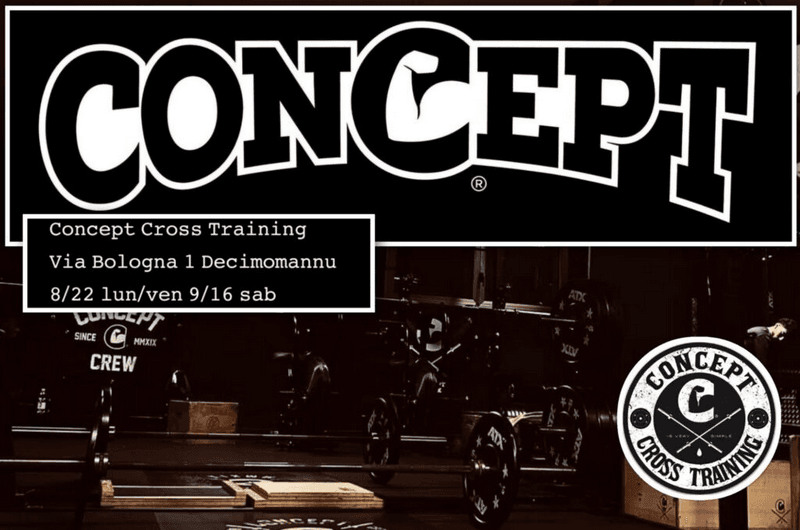La pintadera è tra gli elementi più iconici della cultura sarda: di forma circolare e di piccole dimensioni, questo oggetto in terracotta aggiunge fascino al misterioso periodo nuragico.
Il nome pintadera deriva dal termine spagnolo pintado che significa dipinto. Allo stato attuale in Sardegna questi reperti sono classificati come timbri nuragici per il pane e non è escluso che venissero utilizzati durante rituali religiosi di benedizione. Reperti simili sono stati rinvenuti anche in altre parti del mondo, appartenuti ad altre culture ed erano impiegate per il medesimo scopo: marchiare pelli, stoffe e pani.
Oltre all’interpretazione ufficiale, per ovvi motivi la più accreditata, negli ultimi anni si sta diffondendo tra gli appassionati anche una seconda ipotesi secondo la quale le particolari geometrie impresse potrebbero essere state concepite anche, o forse soprattutto, a scopo calendariale.
Queste geometrie infatti potrebbero essere basate sulle osservazioni dei principali cicli della natura, sia celesti sia biologici, con un focus sul rapporto tra l’uomo nuragico e gli astri e in special modo quello tra Venere e la Dea Madre.
Le decorazioni così non sarebbero altro che algoritmi matematici e ognuna di esse farebbe riferimento ad uno specifico ciclo naturale. Secondo questa ipotesi ogni ciclo sarebbe identificato per mezzo di un ideogramma: alcuni esempi si trovano nelle pintadere di Santu Antine, di Barumini e di Irgoli, dove l’iconografia della stella a cinque punte indica la correlazione del manufatto al ciclo di Venere.
Tramite la pintadera di Santu Antine è possibile ancora oggi prevedere con largo anticipo la posizione del pianeta Venere nella volta celeste durante un periodo di otto anni chiamato “Octaeteride”.
Con il termine “Octaeteride” si indica un ciclo di otto anni solari durante il quale si manifestano novantanove lunazioni, ossia otto anni lunari di cui tre embolismici ossia soggetti all’introduzione di un mese intercalare comunemente noto come “tredicesima luna”. Questo periodo ottennale fu utilizzato dai Greci intorno al 600 a.C. con lo scopo di armonizzare il calendario lunare con quello solare.


La pintadera rinvenuta nella capanna 7 b nel complesso nuragico di Genna Maria a Villanovaforru potrebbe suggerire tra l’altro che il sapere astronomico adottato da altri popoli del Mediterraneo, come ad esempio i Greci, fosse influenzato proprio dalle cultura nuragica, di secoli precedente.
Nelle pintadere elementi geometrici come tacche, cerchi e fori sono impressi a crudo nella totale superficie di una delle due facce, mentre il retro è liscio e presenta una presa apicale a sezione circolare.
Lo scopo di questo calendario sarebbe stato quello di armonizzare tre cicli: quello lunare, solare e venusiano, affidando al Sole il compito di tenere il tempo delle stagioni lungo tutto il periodo ottennale.
Il metodo di calcolo è così efficace da poter essere utilizzato anche ai nostri giorni, poiché fa riferimento all’osservazione di solstizi ed equinozi lungo la linea dell’orizzonte.
La linea immaginaria dell’orizzonte, dividendo in due parti la pintadera, fa si che l’iconografia del Sole in fase di tramonto o di levata si palesi in un modo abbastanza esplicito permettendo nell’oggetto l’identificazione dei solstizi ed equinozi durante il percorso calendariale.
In altri termini l’orizzonte funge da linea equinoziale lungo la quale, in modo apparente, il Sole nel corso di un anno si sposta a destra e sinistra in un raggio di circa 70 gradi (se osservato dalla nostra latitudine, 40° parallelo nord).
Sviluppo del computo
In questo metodo di calcolo gli otto anni del calendario sono distribuiti in due cicli di quattro anni. La registrazione dello scorrere del tempo avviene per i primi quattro anni in una parte della pintadera trascorsi i quali l’oggetto sarà ruotato di 180° in vista della marcatura dei successivi quattro anni.
Nella prima parte del computo saranno quindi considerate solo la metà delle geometrie presenti nella pintadera, fatta eccezione del foro centrale perché condiviso dalle due parti del calendario. Ipotizzando che l’inizio del calendario coincida con il solstizio d’estate, tramite un bastoncino o spillone i giorni inizieranno a essere conteggiati in senso antiorario partendo dal foro in basso a destra (fig. 1).
Il quattordicesimo giorno è annotato nel foro centrale, da lì in poi i giorni saranno conteggiati a ritroso, quindi in senso orario, fino a tornare al foro iniziale che conteggiato due volte indicherà sia il giorno uno che il ventisettesimo.
La registrazione del ventottesimo giorno avverrà con la marcatura di una delle tredici tacche atte ad annotare il fluire dei mesi.
Giacché l’intenzione di questo metodo è in primo luogo quella di stabilire con precisione e largo anticipo l’arrivo di solstizi e di equinozi, è ragionevole ipotizzare che la registrazione dei mesi avvenisse con la marcatura delle tacche in modo alternato, poiché saranno proprio le tacche con la loro marcatura a stabilire la posizione angolare del sole durante l’anno rispetto ai punti cardinali est ovest.
Nella fig. 2, è rappresentato il computo di un anno solare.
Nel settore A sono resi visibili i 14 fori atti al conteggio dei giorni. A scopo illustrativo negli esempi, sono riportati con il colore blu i giorni registrati in senso antiorario (dal giorno 1 al giorno 13), di rosso i giorni registrati in senso orario (dal 14esimo al 27esimo); questa semplificazione è utile per comprendere la precisione del calendario.
Nel settore B è reso manifesto con il colore giallo che il primo mese a essere conteggiato sarà annotato nella seconda tacca di destra, poiché la prima è riservata all’annotazione dell’ultimo mese dell’anno.
Nel settore contrassegnato con la lettera C è reso evidente che sia la tacca del terzo ciclo che il foro che conteggia il settimo giorno del quarto ciclo (91 giorni dal solstizio d’estate), indicano la centrale posizione del sole rispetto allo scostamento annuale tra i due solstizi, indicando così sia in modo figurato che matematico il giorno dell’equinozio d’autunno.
Nel settore D è resa evidente l’annotazione del solstizio d’inverno tramite il foro marcante il 15esimo giorno del settimo ciclo, ossia il 183esimo giorno dal solstizio d’estate.
Nel settore E è riportata l’annotazione dell’equinozio di primavera tramite il 21esimo giorno del decimo ciclo (273 giorni dal solstizio d’estate), la marcatura di questo giorno avverrà nello stesso foro utilizzato per l’annotazione dell’equinozio d’autunno.
Nel settore contrassegnato con la lettera F, è illustrata l’annotazione del solstizio d’estate tramite la marcatura di uno dei tre semicerchi concentrici posti al centro del manufatto, tale annotazione avverrà il giorno seguente la marcatura del tredicesimo ciclo.
Come illustrato nella figura in basso, i quattro anni di questa prima fase di calcolo saranno annotati al centro della pintadera: tre anni saranno registrati nei tre semicerchi, la conclusione del quarto anno sarà annotata nel foro centrale, il 1460esimo giorno dall’inizio del computo.
Come illustrato nell’immagine in alto a destra, completata questa prima fase di calcolo, la pintadera dovrà essere ruotata di 180° in modo da posizionare sulla linea dell’orizzonte la seconda parte del computo.
Questo riposizionamento sarà compiuto il 1462esimo giorno, ossia quello successivo al termine del quarto anno solare e tale operazione servirà a conteggiare ciò che noi identifichiamo con il nome di “giorno bisestile”.
Cos’è il giorno bisestile?
L’anno tropico o anno solare è il tempo che la terra impiega per compiere un giro completo attorno al Sole e dura 365 giorni, 5 ore e 48 minuti (365,256 giorni).
Tutti i calendari, compreso il nostro Gregoriano, si basano su numeri interi. Il fatto che le 5 ore e 48 minuti in eccesso al termine di ogni anno non possano essere conteggiate fa sì che passati quattro anni queste ore e minuti vengono sommate formando un giorno in più: il “giorno bisestile”. Questo giorno è quindi utilizzato per scongiurare lo slittamento delle stagioni.
Come mostrato nell’immagine qui sopra, la ripetizione del computo conduce alla conclusione del calendario ottennale.
Come già noto grazie al codice di Dresda, anche la civiltà Maya osservava il pianeta Venere: era per loro necessario conoscere costantemente la sua posizione nel cielo poiché da essa dipendevano questioni politiche e religiose.
Venere era considerato dai Maya un Dio crudele e sanguinario, associato quindi alla guerra. Dal calcolo della sua posizione dipendevano eventi come l’incoronazione di un nuovo re o una dichiarazione di guerra, che sarebbe avvenuta quando Venere tornava visibile in cielo dopo un periodo di invisibilità.
Nella mitologia Maya Kukulcàn (il serpente piumato), compiva un viaggio nel mondo inferiore simboleggiato dalla scomparsa e ricomparsa di Venere nel cielo. La sua visibilità avviene in due cicli di circa nove mesi, intervallati da due cicli di 8 e 50 giorni nel corso dei quali il pianeta non sarà visibile.
Gli astronomi Maya riuscirono a individuare il periodo sinodico di Venere, ossia il tempo che il pianeta impiega se osservato dalla terra a ritornare nella stessa posizione in cielo rispetto al Sole, notando che il pianeta durante questo periodo sarebbe stato visibile al mattino per 263 giorni, invisibile per 50, per 263 sarebbe stato visibile al tramonto e nuovamente invisibile per altri 8 giorni (263+50+263+8=584).
Appresero che per vedere il pianeta ritornare nella stessa posizione nel cielo rispetto a una stella lontana dovevano aspettare circa otto anni terrestri (365,256 x 8 = 2922 giorni). Cinque periodi sinodici del pianeta Venere corrispondono approssimativamente ai nostri otto anni solari (584 x 5 = 2920), con un anticipo di due giorni rispetto al calendario solare.
Durante questi otto anni si susseguono alternativamente dieci congiunzioni (allineamenti tra Terra, Venere, Sole): cinque superiori e cinque inferiori. Si chiama “congiunzione superiore” quando Venere passa dietro il Sole e “congiunzione inferiore” quando Venere passa tra la Terra e il Sole.
A ogni congiunzione inferiore segue una congiunzione superiore e viceversa. Quando si presenta una congiunzione avviene una transizione: Venere da “stella del mattino” diventa “stella della sera”, oppure da “stella della sera” diventa “stella del mattino”.
Nel caso di una congiunzione superiore l’orbita venusiana conduce il pianeta dietro il Sole e durante questa fase Venere non sarà visibile dalla Terra per circa 50 giorni, trascorsi i quali sarà nuovamente possibile la sua osservazione al tramonto e a sinistra rispetto al Sole.
Quando invece accade una congiunzione inferiore, Venere passa tra la Terra e il Sole e durante questa fase a causa della vicinanza con la stella, il pianeta non sarà visibile dalla Terra per circa otto giorni, trascorsi i quali sarà possibile osservarlo non più al tramonto ma bensì poco prima dell’alba e a destra rispetto la posizione del Sole.
Come mostra la figura sottostante, nella pintadera di Santu Antine (Complesso nuragico di Santu Antine, Torralba XII°-X° sec. a.C.) si palesa l’inequivocabile rappresentazione ideografica di tali congiunzioni. Sempre secondo questa interpretazione l’osservazione dell’alternanza delle congiunzioni inferiori e superiori sarebbe avvenuta in maniera posizionale, ossia in base alla posizione delle tacche durante la loro marcatura che sarebbe avvenuta in senso orario.
Come nella Pintadera di Genna Maria anche in quella di Santu Antine le tacche indicano i mesi da 28 giorni e i fori il numero di giorni da conteggiare con l’ausilio di un bastoncino, ma a differenza della precede Pintadera la loro marcatura comprende tutti i ventisette fori dell’oggetto senza alternare il senso di marcatura.
La rotazione dell’oggetto in senso opposto alla marcatura avrebbe permesso al calendario di seguire la traiettoria dell’orbita venusiana durante l’intero computo, indicando la sua posizione nel cielo rispetto al sole e quando il pianeta sarebbe stato “stella del mattino” o “stella della sera”.
Questa rotazione sarebbe stata possibile adagiando la pintadera su una superficie piana e forata, in modo che la presa apicale leggermente umbonata presente sul retro dell’oggetto, fungendo da perno avrebbe reso possibile tale rotazione e nel contempo stabilizzato il manufatto.
Come mostrato sopra nell’immagine la linea immaginaria che divide in due parti la pintadera rappresenta l’orizzonte, il foro centrale il Sole e le tre file di fori il succedersi delle congiunzioni inferiori e superiori. I due settori decorati con motivi a Chevron evidenziati nell’immagine con il colore rosso, indicherebbero l’intero periodo sinodico di Venere, poiché il numero di tacche in essi contenuti (venti) si avvicina al numero di mesi da 28 giorni presenti nel periodo sinodico.
Fig. 338 Traiettoria venusiana rispetto al sole durante un ciclo sinodico.
Figura 339
Come illustrato nella figura 339, il calendario avrebbe inizio al primo apparire di Venere dopo una congiunzione inferiore (all’alba e a destra rispetto al sole), da quel momento lo scorrere dei mesi sarà annotato in senso orario, inizialmente nelle tacche del settore a Chevron di destra (settore 1), poiché la loro marcatura coinciderà con il periodo in cui Venere è visibile al mattino.
La conclusione di questo primo settore di tacche (10=280 giorni) indica circa metà ciclo sinodico venusiano, a questo punto la pintadera sarà ruotata in senso opposto alla marcatura (quindi in senso antiorario) di due settori a Chevron (settore 2 e 3), che saranno posizionati sopra l’immaginaria linea dell’orizzonte e rappresenteranno un intero ciclo sinodico.
La prima congiunzione superiore (Terra, Sole, Venere) avverrà tra la marcatura dell’ultima tacca del settore 1 appena conteggiato (destro) e la prima del settore successivo che dopo la rotazione risulterà sul lato sinistro rispetto al simbolo solare impresso al centro della pintadera.
Nove giorni dopo la marcatura della prima tacca del settore n. 2, Venere apparirà nuovamente, ma al tramonto, quindi a sinistra rispetto al sole, dopo un periodo di invisibilità di circa 50 giorni.
Per i seguenti nove mesi Venere si potrà osservare esclusivamente nelle ultime fasi della giornata, poi si avvicinerà così tanto al sole da impedirne l’osservazione: sorgerà otto giorni dopo come stella del mattino per i successivi 10 mesi che saranno registrati nel settore n. 3.
Completati questi altri due settori a Chevron, la pintadera dovrà essere nuovamente ruotata di circa 140° in modo da riposizionare sopra la linea dell’orizzonte altri due settori di motivi a Chevron (4 e 5), che rappresenteranno un secondo periodo sinodico del pianeta Venere.
La conclusione del secondo ciclo sinodico venusiano sarà coincidente con il completamento delle 52 tacche presenti nella pintadera: un giorno intercalare sarà inserito con la marcatura del cerchio impresso al centro del manufatto: avrà il compito di tenere traccia dei 1457 giorni precedentemente conteggiati (52×28+1=1.457).
Durante questo giorno intercalare la pintadera sarà ripulita dal pigmento utilizzato nelle fasi di marcatura dei mesi e questa pratica consentirà all’oggetto di essere riutilizzato una seconda e ultima volta. Infatti, ripetendo l’operazione dopo altri 1.456 giorni, Venere per la quinta volta in questo ciclo ottennale si accingerà verso l’ultima congiunzione inferiore, rendendosi invisibile dall’osservazione terrestre, per poi risorgere dopo otto giorni nella stessa posizione zodiacale registrata otto anni prima (2921 giorni).
Posizione di Venere durante il periodo sinodico.
Oltre a stabilire con largo anticipo quando Venere sarebbe stata stella del mattino o stella della sera, in questa pintadera sarebbe anche stato possibile ottenere altre informazioni astronomiche riguardanti questo pianeta, come ad esempio la posizione nel cielo rispetto al Sole durante un intero ciclo sinodico.
Questo dato arriverebbe dalla posizione delle tacche nei diversi settori a Chevron, in quanto sarebbe proprio la loro marcatura mese dopo mese a indicare in modo approssimativo la traiettoria e il periodo di massima elongazione venusiana rispetto al piano dell’eclittica terrestre.
L’orbita di Venere è quasi circolare, ma dalla terra questo dettaglio non può essere colto a causa del punto di osservazione. Per fare un esempio è come guardare una ruota da tre prospettive differenti: frontalmente appare come un cerchio, lateralmente come una linea retta e a tre quarti come una ellisse.
Se dallo stesso punto di osservazione tutte le mattine si annotasse la posizione in cielo di Venere tra una congiunzione inferiore e una congiunzione superiore, dopo i 292 giorni unendo i punti si ricaverebbe una figura “a goccia”.
Lo stesso discorso vale per il periodo che separa una congiunzione superiore da una inferiore: in questo caso l’osservazione andrebbe fatta al tramonto e poiché lo sguardo sarà indirizzato verso l’altra parte del pianeta Terra (ovest) la direzione che Venere assumerà in fase di allontanamento e avvicinamento al Sole sarà percepita e raffigurata in maniera speculare rispetto la precedente osservazione (Fig. 338).
Sovrapponendo il disegno creato dalla traiettoria venusiana nel cielo terrestre durante un intero ciclo sinodico ai due settori di tacche atti a rappresentare tale ciclo, si osserva come sia possibile individuare in questi le fasi di elongazione del pianeta suddividendo in quattro triangoli scaleni i due settori.
Fig. 338
Fig. 340
Nell’immagine 340, il triangolo di colore azzurro nel settore sinistro indica la porzione di cielo rispetto al sole dove Venere sarebbe visibile tra una congiunzione superiore e il periodo di massima elongazione est (massima distanza angolare dal Sole), sempre nello stesso settore il triangolo rosso indicherebbe la porzione di cielo dove Venere sarebbe visibile tra il momento di massima elongazione est e una congiunzione inferiore. Si parla di elongazione est quando il pianeta segue il tramonto del sole, e di elongazione ovest quando invece si palesa durante la levata.
Nel settore destro il triangolo rosso indicherebbe la porzione di cielo dove Venere sarebbe visibile tra una congiunzione inferiore e il periodo di massima elongazione ovest, nello stesso settore il triangolo di colore azzurro indicherebbe la porzione cielo dove Venere sarebbe visibile tra il periodo di massima elongazione ovest e una congiunzione superiore.
Il punto di intersezione tra le tacche del triangolo blu con quelle del triangolo rosso, determinano approssimativamente la distanza angolare dal Sole durante la fase di marcatura, indicando quindi l’elongazione massima quando la marcatura dei mesi avverrà nelle tacche più corte e la minima quando la marcatura dei mesi avverrà nelle tacche più lunghe.
Pintadera di Genna Maria n° 2
Datata intorno al IX°-XIII° secolo a.C. anche questa pintadera come la prima proviene dal villaggio nuragico di Genna Maria a Villanovaforru.
Come mostrato nella figura sottostante l’inserimento dell’ipotetica linea d’orizzonte nella pintadera di Genna Maria n° 2 evidenzia l’inscindibile legame con la dea lunare Tanit.
L’immagine iconografica sarebbe composta da tre elementi: la linea d’orizzonte, la Luna e il suo riflesso nel mare. Questo particolare tende a rafforzare l’ipotesi che in questa pintadera sia possibile calcolare lo stesso periodo ottennale registrato sia nella Pintadera di Santu Antine che in quella di Genna Maria n° 1.
Come già scritto in precedenza con il termine “Octaeteride” è indicato un periodo della durata di otto anni solari (2922 giorni) durante il quale si presentano esattamente 99 lunazioni, ossia otto anni lunari (354 giorni) in cui tre di questi sono definiti embolismici, ossia che possiedono un tredicesimo mese intercalare. Il fine di una Octaeteride è quello di armonizzare il calendario lunare con quello solare.
Il metodo di calcolo presentato nell’immagine sottostante si basa nella registrazione di otto anni lunari. Questo metodo divide la pintadera in quattro settori e in ogni settore è possibile annotare il fluire di due anni lunari. Nel computo i cerchi concentrici centrali sono condivisi dai quattro settori poiché la loro funzione è quella di annotare le 12 lunazioni di ogni anno lunare.
La figura contrassegnata dalla lettera A mostra la marcatura della prima tacca del computo, evidenziando come questa sia avvenuta il giorno seguente il completamento di un ciclo di 21 fori (giorni).
La figura contrassegnata dalla lettera B mostra l’avvenuta marcatura delle prime otto tacche (22 x 8 = 176) con la marcatura di uno dei due cerchi concentrici centrali, specificando che quest’ultima avverrà con un giorno di distacco.
La figura C mostra come la ripetizione del calcolo avvenuto nella figura B conduca al raggiungimento di un anno lunare (354 giorni).
Nella figura D è indicato il punto dove sarà annotato l’anno appena conteggiato.
Nella figura E si illustra l’annotazione del secondo anno lunare del primo settore.
La figura F espone la completa marcatura dei quattro settori (otto anni lunari).
Come reso noto dal risultato del conteggio, il calendario lunare è ancora ben lontano dalla sincronia con il calendario solare mostrando un distacco di 90 giorni; tuttavia per raggiungere tale sincronia basterebbe inserire nel calendario (con una logica ancora da definire) i tre mesi intercali previsti nella Octaeteride. 2.832 +30+30+30= 2.922
Nonostante l’efficacia e la semplicità del metodo appena esposto, di seguito verrà presentata una versione alternativa che oltre a donare al calendario più precisione di calcolo, lo arricchisce di informazioni astronomiche basate sull’osservazione di solstizi e equinozi.
Una serie di ingegnosi e logici espedienti, trasformano difatti il calendario da lunare a solare, introducendo al termine di ogni anno lunare gli undici giorni che separano i due calendari. Lo stratagemma risiede nella marcatura delle tacche e dei cerchi che possono essere conteggiati sia tramite l’applicazione del pigmento che con la rimozione dello stesso.
Nell’immagine sottostante sono indicate le tacche che nel computo indicheranno il verificarsi dei solstizi e degli equinozi durante l’anno calcolato. La marcatura delle tacche che nell’algoritmo indicano i cicli di 22 giorni, seguono nel corso dell’anno l’apparente movimento del sole lungo l’orizzonte.
Per otto cicli di 22 giorni le tacche verranno contrassegnate da destra verso sinistra (dal solstizio d’estate a quello d’inverno), per gli altri otto cicli di 22 giorni, le tacche saranno contrassegnate da sinistra verso destra (dal solstizio d’inverno al solstizio d’estate).
L’immagine 341 mostra come il procedimento fondamentalmente sia lo stesso del precedente computo, mentre l’immagine 342 mostra tutte le differenze.
Nell’immagine in basso a destra si nota che la marcatura delle otto tacche che conducono al calcolo dell’anno lunare è avvenuta con la rimozione del pigmento precedentemente utilizzato.
Questa operazione ha un fine pratico, poiché in quelle tacche saranno conteggiati otto degli undici giorni in difetto nell’anno lunare rispetto a quello solare. Il nono giorno sarà conteggiato con la marcatura dell’anno nel cerchio atto a tale fine, mentre il decimo e l’undicesimo saranno conteggiati con la rimozione del pigmento precedentemente utilizzato nei due cerchi concentrici centrali.
Anche quest’ultima operazione oltre a un fine matematico ne possiede uno pratico poiché libera dal pigmento i due cerchi concentrici che dovranno essere riutilizzati nel successivo calcolo dei semestri negli altri settori.
Fig. 341
Fig. 342
La sequenza di figure riportata nell’immagine in basso mostra come il metodo appena applicato, se ripetuto per il numero di cerchi atti alla registrazione degli anni solari (otto), conduca con una buona approssimazione al termine del periodo ottennale, con un difetto di soli due giorni. Questo difetto potrà facilmente essere corretto conteggiando i due giorni mancanti negli unici spazi ancora liberi della pintadera, ovvero i due cerchi concentrici centrali. Questa ulteriore operazione condurrà il calcolo a 2.922 giorni dal suo inizio e il ciclo venusiano, il ciclo solare e quello lunare saranno nuovamente sincronizzati.
Siamo arrivati alla fine di questo lungo articolo e come detto all’inizio questa è solo un’ipotesi che andrebbe eventualmente sviluppata e approfondita. Come ha recentemete ricordato il prof. Giovanni Ugas, attualmente il massimo esperto in materia, oltre il 90% della cultura nuragica è ancora da scoprire per cui c’è tanto da fare, sia a livello accademico che da semplici appassionati. Nonostante l’azione del tempo, e soprattutto dell’uomo, la Sardegna ospita ancora oggi decine di migliaia di testimonianze straordinarie. Sta anche a noi conoscerle e valorizzarle, anche perché se non lo facciamo noi chi lo farà?