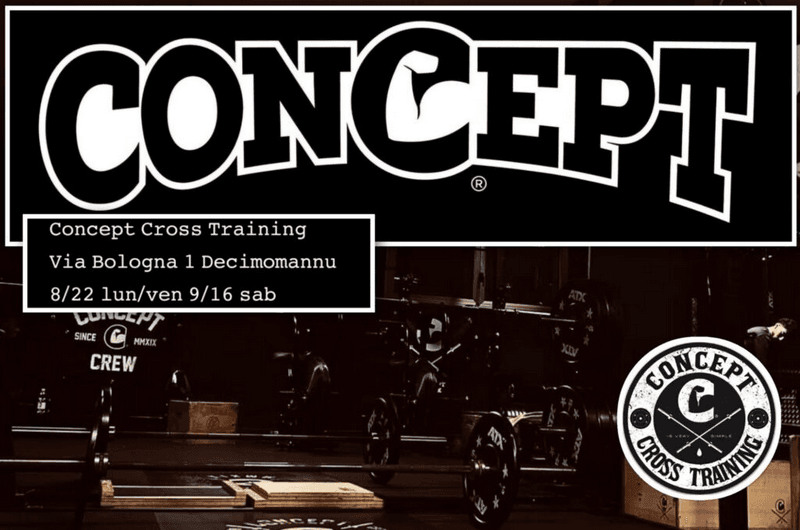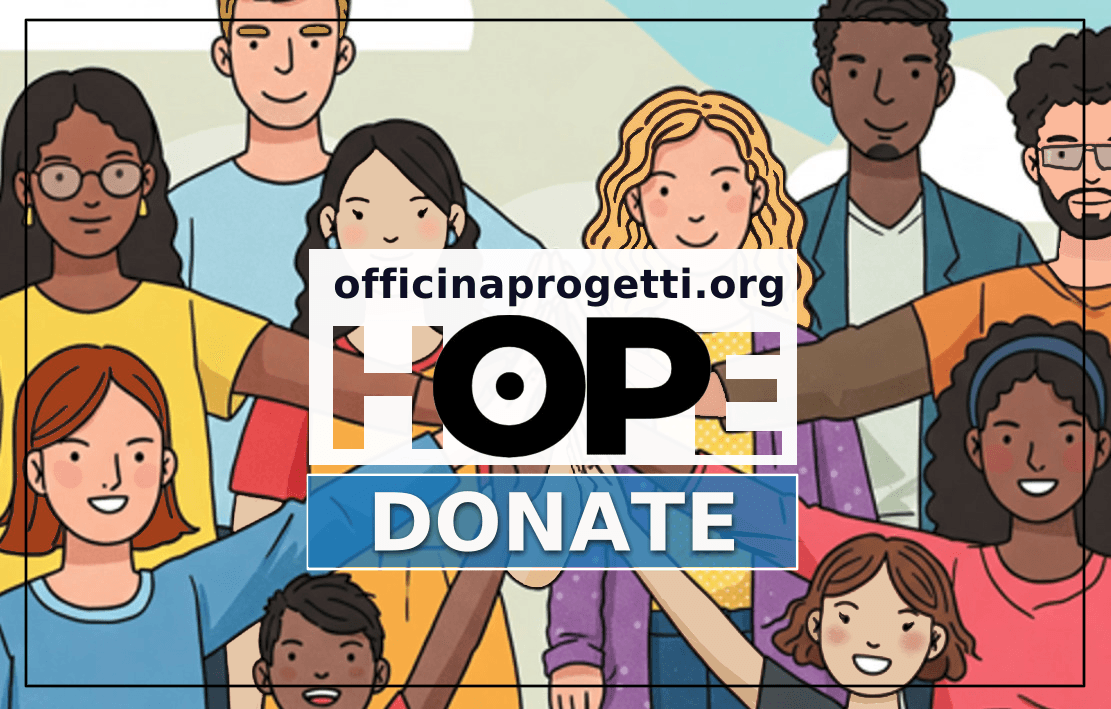Nel panorama del cinema iraniano contemporaneo, Jafar Panahi non è solo un regista, è un simbolo di resistenza artistica e una voce della coscienza collettiva.
Tre volti, in lingua persiana سه رخ, il suo quarto film realizzato nonostante la condanna del 2010 che gli vieta di dirigere pellicole per 20 anni e di lasciare l’Iran, è molto più di un’opera cinematografica.
È un atto di sfida, un diario di viaggio e una profonda riflessione sulla condizione della donna, sulla libertà creativa e sulle complesse geografie umane dell’Iran rurale.
Presentato in concorso a Cannes nel 2018, dove ovviamente Panahi non poté essere presente, il film si colloca nella serie delle sue opere clandestine.
Tre volti si apre con un video inquietante sul cellulare della nota attrice Behnaz Jafari, che interpreta se stessa. Una giovane aspirante attrice, Marziyeh, dichiara di essersi suicidata perché la sua famiglia le impedisce di studiare recitazione. Sconvolta, Behnaz coinvolge il regista Jafar Panahi, anche lui nel ruolo di se stesso, e insieme partono per il remoto villaggio della ragazza, nel nord-ovest dell’Iran, per indagare.

Il viaggio si trasforma in un’avventura stile Kafka e al tempo stesso profondamente umana. Attraverso una struttura a matrioska, il film esplora tre livelli di rappresentazione femminile, i cosiddetti tre volti del titolo.
Marziyeh, la giovane disperata che rappresenta le nuove generazioni in lotta contro il conservatorismo sociale e familiare.
Behnaz Jafari, l’attrice affermata ma comunque soggetta a limitazioni e ipocrisie, ponte tra il mondo urbano/artistico e quello rurale/tradizionale.
Shahrazad, una misteriosa e leggendaria cantante d’opera del passato, il cui ricordo è bandito ma sopravvive nella memoria delle donne del villaggio, simbolo del talento represso e della tradizione cancellata.
La linea tra realtà e performance si confonde continuamente, Marziyeh è realmente in pericolo o sta recitando una parte disperata?
Il film gioca con il documentario e la finzione, coinvolgendo lo spettatore in un’indagine morale ed emotiva. L’incontro con la comunità rurale è un microcosmo di contraddizioni, l’ospitalità si mescola alla diffidenza, il patriarcato si scontra con la solidarietà femminile sotterranea, il mito si intreccia con il quotidiano.

Privato dei mezzi tradizionali, Panahi adopera uno stile minimalista, intimo e apparentemente informale. Le riprese sono spesso in movimento, su strada, tra i sentieri di montagna. L’umorismo, tipico del regista, affiora nelle situazioni assurde, come l’incontro con il toro o le discussioni con gli anziani, alleggerendo la tensione senza sminuire la gravità dei temi.
La forza del film risiede nella sua autorialità riflessiva. Panahi mette in scena se stesso come un regista impotente, che cerca di capire e aiutare, ma in realtà spesso può solo osservare. Questa auto-rappresentazione è un potente commento sulla sua condizione, un artista ridotto a spettatore nella sua stessa terra, ma che non smette di guardare, di interrogare, di filmare.
Panahi non è nuovo a questi film. Nelle sue opere ha sempre posto al centro dei suoi film gli emarginati, le donne, i bambini, criticando con sguardo lucido e umano le ingiustizie sociali. La condanna invece di spegnerlo ha di fatto trasformato la sua persecuzione in una formidabile fucina creativa.
I film vengono realizzati nel segreto con mezzi di fortuna, smartphone, piccole telecamere, e il regista ha fatto del confine tra privato e pubblico, tra interno ed esterno, tra lecito e illecito, il suo campo d’indagine. La sua arte è ancora una volta la prova che la creatività non può essere incarcerata.
Tre volti si conclude senza un finale risolutivo, ma con un’immagine di struggente poesia e di speranza testarda. È un film che interroga il potere delle storie, quelle che ci imprigionano e quelle che ci liberano. È soprattutto un tributo alla resilienza delle donne iraniane, custodi di sogni e di memorie proibite.